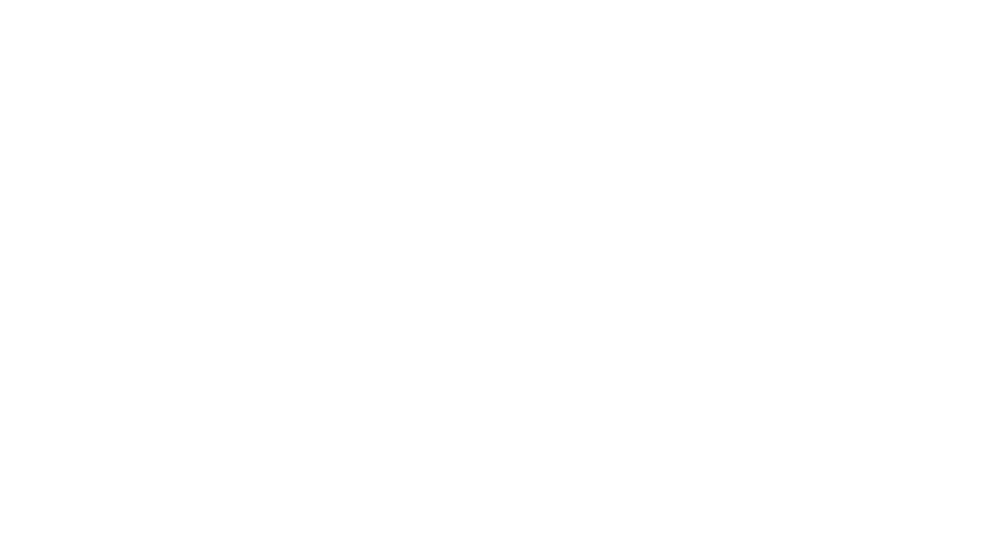A volte può capitare che, nonostante si siano trascorse molte giornate alle prese con manuali e appunti delle lezioni, il voto ottenuto all’esame non rispecchi quelle che sono le aspettative. Ma aspettative di chi, esattamente?
Tra aspettative social e genitoriali sull’università e sui voti
Quello che noi prefiguriamo come obiettivo ideale del nostro labor non è altro che il risultato di una inanimata commistione tra i nostri desideri, incanalati in una prospettiva strettamente edonistica, e quello che la società si aspetta da noi. Vivere in un mondo estremamente performativo rischia di farci sentire, molto spesso, non all’altezza delle “sfide” che ci si presentano davanti ogni giorno. Le continue notizie di studenti che battono ogni record di precocità, diffuse tramite quotidiani e telegiornali, acuiscono e intensificano quella sensazione di inadeguatezza che ogni giovane ha provato almeno una volta nella sua vita. Contribuiscono a porre dei canoni irreali che creano disagio nei ragazzi con un carattere fragile e che, magari, non si sono lasciati fagocitare da quell’imperversante spirito di competizione che molto spesso si manifesta nelle aule degli atenei.
A tutto ciò si aggiunge l’impatto dei social media che, in un tempo come il nostro in cui il valore di una persona si misura quasi esclusivamente in base all’apparenza e all’esteriorità, si trasforma in una insidiosa cassa di risonanza che rimbomba costantemente nella mente di chi, non riuscendo a ottenere quell’affermazione, si sente un completo fallimento.
Per dare voce a questa narrazione sapientemente artefatta, in cui si sottolinea la straordinarietà del merito di chi si laurea nella metà del tempo e con il massimo dei voti, non si lascia spazio all’ordinario, a tutti gli studenti “normali” che fanno i conti con le delusioni e i costi, psicologici ed economici, della vita universitaria.
Un altro aspetto da non escludere è il terrore di vedere un genitore deluso a fronte della nostra mancata aderenza a quell’etichetta di “studente di successo” a cui altri, invece, hanno saputo dar forma. Tutti questi fattori costituiscono una climax di rischio, un incubo, una vorticosa spirale che, non raramente, porta a situazioni drammaticamente critiche. E, purtroppo, al grido silenzioso di molti studenti che si sentono intrappolati in una opprimente e asfissiante dimensione di malessere, molto spesso risponde la cruda indifferenza.
È compito di ciascuno di noi dare attenzione ai campanelli d’allarme e alle richieste d’aiuto di chi ha bisogno di essere confortato, consolato o, semplicemente, ascoltato.
Dal successo dei voti al burnout
Succede anche che, dopo aver conseguito svariati risultati particolarmente positivi, non si sia più in grado di riscuotere ulteriori soddisfazioni, perdendo l’interesse per ciò a cui, fino a quel momento, ci si era dedicati con una devota abnegazione. Negli ultimi tempi si sta usando molto spesso il termine burnout (“bruciare”) che fornisce una esauriente istantanea della complessità del fenomeno. Per pura esperienza personale, posso definire questo momento come un “lutto”; elaborare lo smarrimento di quella che è una parte caratterizzante della propria identità fa quasi perdere la propria essenza, fino a sentirsi quasi senza senso. C’è bisogno di un lavoro di introspezione e riflessione ben strutturato per riconciliarsi con quella frazione di sé stessi, per riscoprirla, per rinnovarla.
Attingendo alla letteratura scientifica che tratta di questo tema, mi sono imbattuta nella figura di Mauro Di Lorenzo, psicologo e socio dell’Istituto Minotauro di Milano dove coordina il gruppo che si occupa dei giovani adulti. Di Lorenzo offre un’interessante epitome della sua esperienza professionale condensandola in un’antologia di casi raccolti dal titolo “Giovani adulti in crisi”. L’autore spiega che, secondo lui, non sarebbe l’università di per sé a produrre malessere. Il problema deriverebbe dalla forma che la società ha impresso all’attuale configurazione universitaria, “caratterizzata da una cultura della performance”. A colpire sono “le università che danno i voti con la gaussiana, favorendo una competizione tra gli studenti e le studentesse”.
Un ruolo fondamentale, secondo lo psicologo, sarebbe anche giocato dalla velocità con cui ci si laurea, mettendo in secondo piano le inclinazioni individuali con cui si affronta la preparazione di una prova d’esame. Altro elemento da evidenziare sarebbe “l’angoscia per i posti limitati, come succede per i master post-laurea”. Sono tutti aspetti che per Di Lorenzo contrastano con l’università “come spazio per esplorare” le possibilità del proprio futuro, e rischi di trasformarlo in un passaggio “obbligato perché fornisce il titolo necessario per il dopo”, quasi si trattasse di un prolungamento della scuola dell’obbligo.
In questo contesto sarebbe difficile tollerare la complessità del mondo. Si perde, così, quello che è il significato ancestrale della stessa parola “università”. Il termine deriva dal latino universitas che, a sua volta, è un corradicale dell’aggettivo universus, il quale significa “tutto intero”. L’Università racchiude un concetto che è molto più ampio e complesso della stessa istituzione che rappresenta. Ed è assolutamente auspicabile che ogni persona che frequenti questo microcosmo di esperienze, moduli il proprio approccio alla dimensione universitaria, classificandola come un percorso per approfondire, imparare e migliorare sé stessi. In fondo, lo studente è, originariamente “colui che desidera, che ambisce, che aspira”. Poi, in un secondo momento, alla parola è stata applicata quella patina modernizzante, che ha spinto a una categorizzazione di tutti coloro che frequentano l’Università, in una fascia sociale. Esattamente come se si trattasse di un impiegato, di un insegnante, di un avvocato o di un medico.
Essere uno studente non è una qualifica professionale ma un habitus. Descrive un processo di evoluzione che può presentare al suo interno varie difficoltà e ostacoli che appaiono insormontabili. Il risultato finale, del resto, è solo un’istantanea di un determinato momento, figlio di un aleatorio caso e di fortuite contingenze. Ciò che conta davvero è il senso che diamo a ogni pagina che leggiamo, a ogni materia che studiamo e a ogni esame che sosteniamo, soprattutto a quelli che non superiamo.
Una lettera per te, student*
Car* student*,
ti scrivo questa lettera perché so cosa significa finire la sessione e sentirsi “non all’altezza”.
All’altezza di che però?
Sono stata bocciata a più di un esame in questa sessione, poiché ho messo tanti esami insieme per finire “in tempo” la triennale.
Il mio esempio vuole farti capire che non ha senso questa fretta di finire un percorso perché ci si deve sentire all’altezza.
Questa fretta mi ha regalato un burnout e tanto stress visibile anche sul corpo: perché mente e corpo sono così collegati, collaborano tra loro.
Ne è valsa la pena?
No.
I miei coetanei si stanno laureando, la maggioranza nella sessione di luglio e mi sento abbastanza “indietro” rispetto a loro.
Però ho avuto le mie.
Sono stata ferma una sessione intera l’anno scorso perché stavo male.
Il mio esempio vuole essere un aiuto per te, per voi.
Quante volte ci siamo sentit* non abbastanza perché non siamo arrivat* alla perfezione del 30 o del 30L?
Quante volte ci siamo sentit* non abbastanza perché non siamo arrivat* a neanche un 27?
Il problema è che questa società è diventata malata di numeri fino ad ossessionarsene.
L’università è il tuo percorso personale.
Personale, ripeto.
Puoi prendere 24 all’esame più importante della tua facoltà ma essere comunque portat* per il lavoro che desideri tanto poter concretizzare.
Questo perché siamo speciali nella nostra unicità, non siamo un numero.
Come non siamo il numero della bilancia, non siamo il numero di ricoveri fatti, non siamo la nostra taglia, non siamo neanche quel numero accademico.
Se sei stat* bocciat* non sentirti un fallimento: pensa piuttosto a cosa è andato storto e passa all’azione, riparti.
La cosa bella dell’università è che gli esami si possono rifare per una propria soddisfazione personale, però deve essere evitata l’ossessione della perfezione.
Non prendi dei voti per i tuoi genitori, per i tuoi amici, per i tuoi familiari, per le persone care accanto a te.
Non prendi dei voti perché devi essere più brav* degli altri, non è una gara, è un percorso.
Quando si và a fare una scampagnata in montagna si và tutt* allo stesso passo?
Scommetto che hai risposto un NO secco.
Stessa cosa con i voti.
Questa lettera è rivolta anche a chi è uscito dalla maturità e non si è sentit* all’altezza di quel numero.
Pure se non hai finito ancora la scuola e sulla pagella non hai i voti che desideri.
Sii te stess* sempre.
Non mollare la presa nelle tue cadute e riprendi con azioni nuove.
Certo, ci possono essere emozioni negative, ecco, sentile fortemente, non cercare di reprimerle.
Non c’è cosa più bella che vivere questa vita di alti e bassi continui.
Più bella che respirare, studiare con piacere e convinzione.
Non c’è cosa più bella che la diversità.
Articolo scritto da Natalia e Chiara, volontarie dell’Associazione