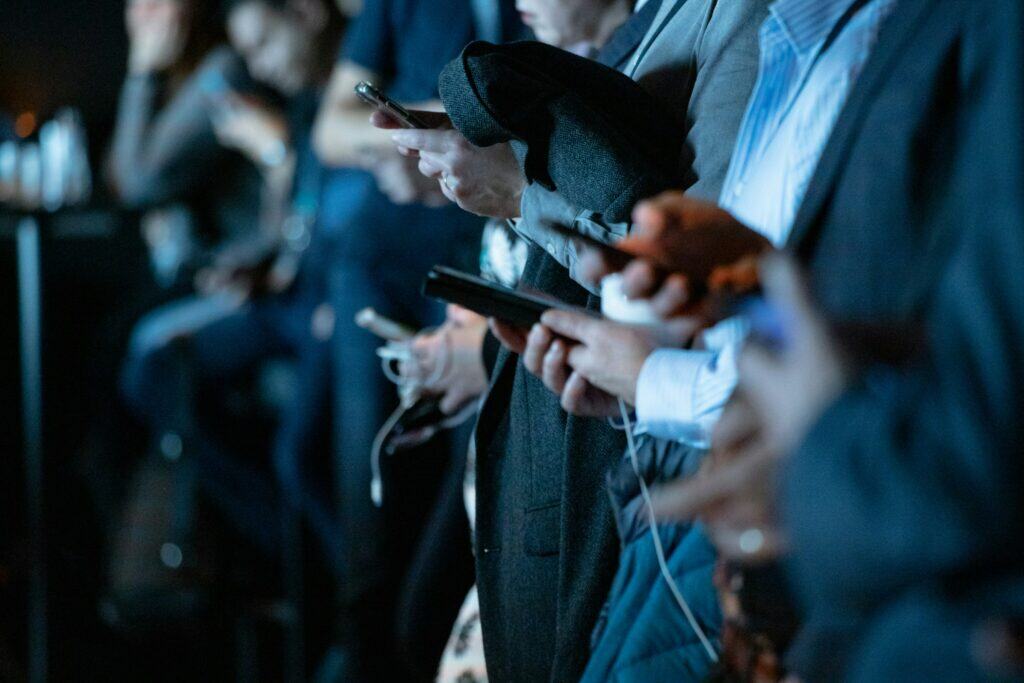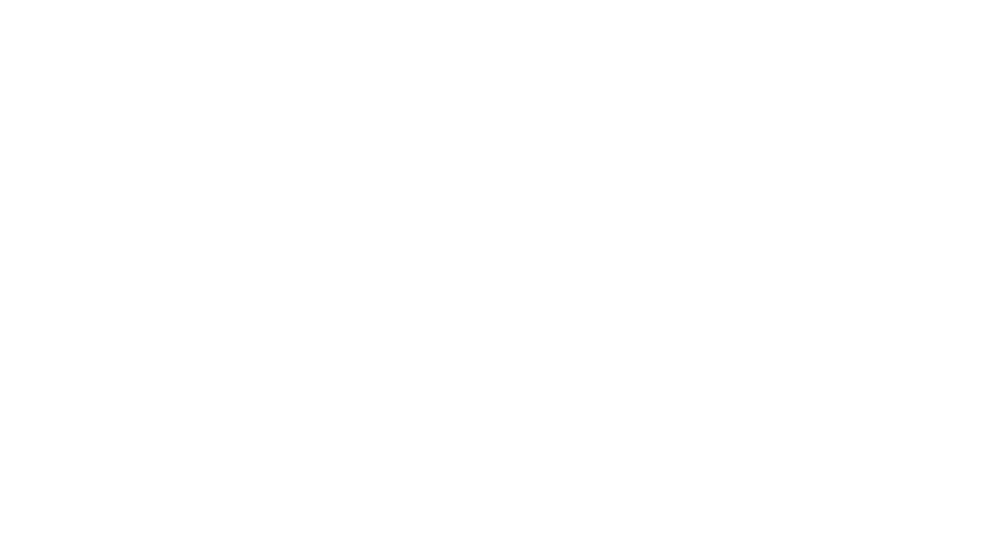Viviamo in un’epoca fortemente caratterizzata (a tratti, ossessionata) dall’esteriorità che è diventata, a tutti gli effetti, un vero e proprio biglietto da visita. L’apparenza è un aspetto talmente rilevante al giorno d’oggi che non solo veicola ciò che gli altri pensano di noi, ma anche il modo in cui comunichiamo.
Oscar Wilde affermava, ironicamente: “Solo le persone superficiali non giudicano dalle apparenze”. Ebbene, se ci si riflette, si può comprendere quanto sia vero, perchè il mondo ci percepisce da come parliamo, vestiamo e parliamo. Le apparenze sono il fondamento di ciò che sappiamo degli altri e di ciò che gli altri sanno di noi.
La rivalutazione delle apparenze
Il concetto stesso di “apparenza” ha subito varie oscillazioni nel corso della storia delle società. Questo è stato aspramente criticato da una certa tradizione “romantica”, che ha sempre considerato il mondo delle apparenze come una realtà inferiore, come regno del futile e del vano, dell’artificio opposto all’autenticità. Da queste premesse prende le mosse il lavoro d’indagine di Barbara Carnevali, docente universitaria di estetica sociale e fondatrice della “filosofia sociale”. Il suo libro Le apparenze sociali, infatti, si configura come un’analisi delle vanità, di quel mondo effimero e volatile in cui rientrano le mode, la fama, il prestigio. Ciò rappresenta, per la filosofa, l’assetto sensibile della società dove vengono rappresentate, come uno spettacolo, le immagini che le persone hanno reciprocamente di sé stesse.
L’apparenza secondo Guy Debord
Nell’intraprendere il suo lavoro, Barbara Carnevali è partita dagli assunti, in fatto di estetica sociale, del filosofo francese Guy Debord.
Sul finire degli anni Settanta, nel suo La società dello spettacolo, Debord scriveva: “Tutta la vita delle società nelle quali predominano le condizioni moderne di produzione si presenta come un’immensa accumulazione di spettacoli. Tutto ciò che era direttamente vissuto si è allontanato in una rappresentazione.”
In questa affermazione, egli riesce a creare una diapositiva perfetta di quello che è lo scarto tra realtà e rappresentazione. La realtà va intesa come ciò che è, mentre la rappresentazione come ciò che appare.
Alla base del graduale processo di cosiddetta “de-materializzazione” del mondo contemporaneo, troviamo l’alto grado di accrescimento scientifico-tecnologico.
Ebbene, tutto ciò era stato intuito mezzo secolo fa da Debord, che si rese conto di vivere dove gli individui stavano progressivamente diventando degli spettatori passivi di un flusso d’immagini accuratamente prodotte e selezionate da un potere spettacolare. Esse, poco alla volta, si stavano sostituendo alla realtà: tale processo andrà, per l’autore, a definire la definizione di spettacolo.
Nel linguaggio comune, il termine spettacolo viene utilizzato per indicare la dimensione mass-mediatica legata all’intrattenimento di una certa audience. Per l’autore, invece, questo ne costituisce soltanto l’aspetto più superficiale e più opprimente.
Dall’apparenza ai mezzi di comunicazione
È possibile constatare la centralità dell’immagine da un dato incontrovertibile. Per rendersene conto basta aprire gli occhi e guardarsi intorno: schermi televisivi e monitor di ogni genere, cartelloni pubblicitari, vetrine e insegne luminose di negozi popolano le strade delle moderne città. Spesso, poi, anche quei luoghi un tempo considerati sacri non sono più totalmente immuni alla dimensione tecnologica della post-modernità. A tutti questi stimoli presenti nell’ambiente sociale nel quale viviamo, e ai quali, spesso, non facciamo più caso, vanno aggiunti quelli derivanti dal crescente numero di gadget tecnologici: smartphone, laptop, tablet etc.
Questi strumenti di comunicazione sono alla portata di mano di chiunque. Rappresentano dei veri e propri “oggetti di culto” che le persone portano costantemente con sé, tanto da non poterne più fare a meno.
Oggi, infatti, se capita di uscire di casa senza il proprio cellulare, si avverte una sensazione di disagio, paragonabile in qualche misura al sentimento del sentirsi “persi”, estraniati dal mondo. Viene così a instaurarsi un rapporto di stretta dipendenza fra l’uomo e questi oggetti-feticci, senza i quali si è esclusi dall’incessante flusso comunicativo-mediatico che avvolge l’ambiente in cui viviamo (la cosiddetta mediasfera). La tecnologia esercita una forma di seduzione molto potente sull’individuo, ipnotizzandolo in uno stato di “narcisistico torpore”. Il rischio cui si va incontro, se non si sviluppano gli “anticorpi” necessari, è di venire fagocitati da questa dimensione narcotizzante, accettando passivamente i messaggi non neutrali intrinsechi alla tecnologia.
L’influenza dei social media sull’immagine e l’apparenza
Il processo di astrazione del vissuto descritto da Debord sembra aver raggiunto un livello tale da estendersi parzialmente anche ai rapporti umani. A rendere più incerta questa situazione liminale, hanno contribuito, nel corso dell’ultimo decennio, le potenzialità offerte dal web, in particolare con la nascita e il rapido affermarsi su scala globale dei famigerati social media.
All’interno dei social media viene a formarsi un micro-mondo virtuale dove è possibile effettuare tutta una serie di operazioni, finalizzate a mettere in (pseudo) relazione gli utenti. Questi social vengono a costituirsi, pertanto, come uno spazio-contenitore fungente idealmente da “vetrina”, una sorta di seconda vita parallela a quella reale. Una vita vissuta su un piano virtuale dove poter edificare e modellare un’immagine, in modo da rispecchiare la percezione che il soggetto ha di sé e di ciò che vuole mostrare agli altri. Tale immagine tende ad essere liquida, ri-definibile facilmente in un qualsiasi momento, qualora lo si ritenga opportuno. Questo, tuttavia, implica una mancanza di controllo effettivo sulla veridicità delle informazioni pubblicate. Chiunque dall’altra parte dello schermo è nella posizione di poter mentire sulla propria identità.
L’effettiva realizzazione dell’ipotesi di Debord
L’impressione è di assistere oggi a un inquietante fenomeno, consistente nella sovrapposizione tra vita reale e quella della sua rappresentazione virtuale. A sostegno di questo sentore, possiamo osservare come un crescente numero di persone sente l’irrefrenabile desiderio o bisogno di utilizzare compulsivamente i social media per condividere ogni sorta di pensiero o azione compiuta, come se l’esperienza dovesse essere mediata dalle immagini per considerarsi in un certo qual modo “reale”.
Quanto previsto da Debord si è, dunque, parzialmente verificato: parte della propria vita è divenuta immagine. Possiamo, inoltre, notare come queste reti sociali, presentino quasi tutte le medesime caratteristiche dello spettacolo descritte dal filosofo: la separazione, l’isolamento, la divisione e la contemplazione.
Alla fine degli anni Sessanta, il principale mezzo di comunicazione di massa era la televisione, un medium caratterizzato da un flusso comunicativo unidirezionale basato su un sistema di trasmissione dove i messaggi viaggiano in una sola direzione: da una fonte emittente a molti riceventi. Grazie alla diffusione della rete internet e del web, questa situazione è cambiata. Il flusso è diventato pluridirezionale. Vi sono molti emittenti e destinatari che possono, in un qualsiasi momento, scambiarsi di ruolo.
I social tendono a presentarsi come strumenti di socializzazione, in quanto ogni utente è unito, connesso a una rete sociale, ma come singolo e separato dalla postazione del proprio computer. La costante rimane, dunque, un certo grado di passività nei confronti della vita: più l’individuo contempla la sua vita virtuale, meno vive quella reale. In quest’ottica viene a crearsi una pseudo-socialità. Debord, con la sua analisi, ha voluto mettere in luce come si sia assistito al passaggio da una realtà ancorata alla materialità (alla concretezza della “cosa”) a una parziale de-materializzazione di essa. Siamo davanti ad un’ibridazione tra due piani d’esistenza.
Quanto conta l’apparenza?
Viviamo in una società, dove sempre di più il nostro immaginario, alimentato dal crescente numero di narrazioni spettacolari, è influenzato dal fatto che le nostre esperienze, corporee ed emotive, tendono a trasferirsi su un piano virtuale (come nel caso dei social). In questa società, la nostra immagine e come decidiamo di mostrarci agli altri diventa fondamentale, anzi vitale. Da essa dipende il nostro modo di relazionarci al mondo. L’apparenza, sui social e poi anche fuori da essa, diventa il nostro primo mezzo comunicativo e, essendo modellabile, possiamo scegliere noi come mostrarci. Un’arma a doppio taglio: siamo noi a scegliere chi siamo o siamo influenzati dalla cultura dell’immagine che ci circonda? Siamo onest*, sincer* e veritier* o scegliamo di raccontarci divers* da come siamo per ottenere approvazione e likes?
Bibliografia
-W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, trad. it. di E. Filippini, Einaudi, Torino 2011;
-B.Carnevali, Le apparenze sociali. Una filosofia del prestigio, Il Mulino, Bologna 2025;
-G. Debord, La società dello spettacolo, trad. it. di P. Salvadori, Baldini Castoldi Dalai editore, Milano 2008;
-R. Simone, Presi nella rete. La mente ai tempi del web, Garzanti, Milano 2012;
-J.J. Wunenburger, Filosofia delle immagini, trad. it. di S. Arecco, Einaudi, Torino 1999.
L’articolo è stato scritto da Natalia, volontaria dell’Associazione