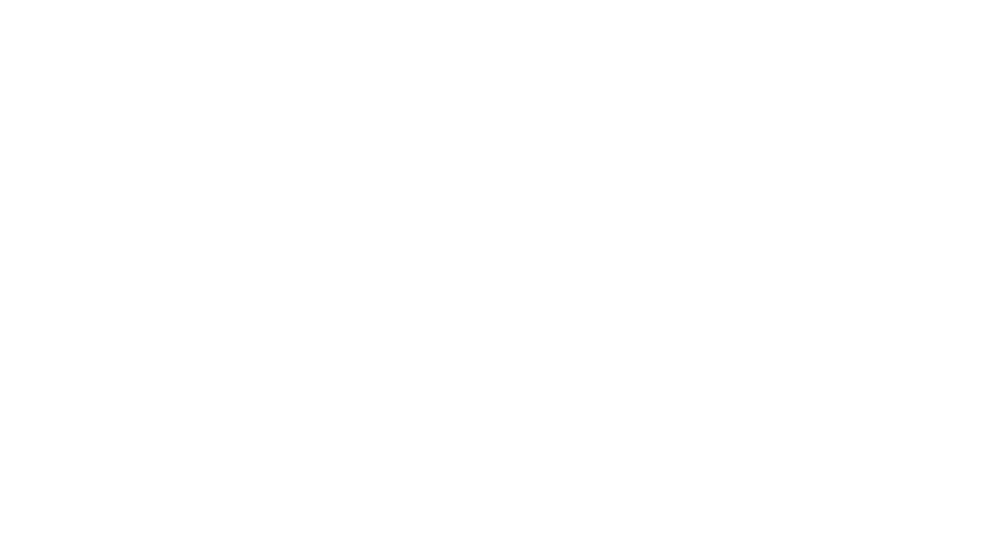Cosa è maschile e cosa è femminile? Ce lo saremo chiesto tutt*, almeno una volta, almeno da bambin*. Perché quella determinata cosa è maschile e quell’altra è femminile? E, per entrare nell’argomento che Animenta ha più a cuore, perché un tipo di DCA è considerato più femminile (o “da femmine”) mentre un altro è più maschile? Anche la nostra salute mentale, allora, segue dei ruoli di genere?
I ruoli di genere nella nostra società
Per affrontare questo argomento, delicato come una rosa e al contempo spinoso come il suo gambo, serve aver chiari in mente alcuni concetti.
In primis, quando si parla di ruoli di genere si parla di ciò che è socialmente e culturalmente definito come maschile o femminile. Il ruolo di genere risponde quindi alla norma sociale e alle credenze condivise dai più che definiscono quali comportamenti si adattano a ruoli maschili o femminili. Secondo le culture, i tempi e le tradizioni, perciò, alcuni comportamenti possono essere considerati più femminili o più maschili.
Qualche esempio? Prendersi cura dei bambini e della casa è storicamente considerato un comportamento più adatto al genere femminile, mentre lavorare e guadagnare il sostentamento familiare è un affare proprio del genere maschile. Ancora, pensare emotivamente e reagire d’impulso è considerato un meccanismo innato del genere femminile, mentre quello maschile viene considerato più razionale, intellettivo.
Insomma, anche nelle cose più banali della nostra quotidianità esistono delle etichette invisibili (ma che il nostro inconscio sociale percepisce fin troppo bene!) che definiscono cosa è maschile e cosa è femminile. E noi ci comportiamo di conseguenza, in base alla nostra identità di genere, ovvero come ciascun individuo sente di essere, il suo sentimento profondo di femminilità, mascolinità o nessuna delle due.
La salute mentale segue dei ruoli di genere?
Onestamente? La prima persona a cui penso per rispondere a questa domanda è Sigmund Freud, lo psicanalista più citato da chi di psicoanalisi a volte sa troppo poco. Insomma, Sigmund Freud è stato uno dei primi studiosi della storia a parlare di “isteria” come di un insieme di disturbi mentali derivanti tutti da un trauma di tipo sessuale nella vita delle pazienti. E qui, piccola postilla dell’autrice, non uso il femminile sovraesteso a sproposito. Nonostante questa mia spiegazione della complessità del pensiero freudiano possa essere decisamente parziale e superficiale, è importante notare come le pazienti studiate dallo psicanalista e da lui diagnosticate come casi di isteria erano esclusivamente donne. Strano? Non so. Analizziamo qualche fatto.
Nell’epoca in cui visse Freud, ovvero nella seconda metà dell’800 (anno più, anno meno), la donna non aveva molte scelte di vita. Fondamentalmente, le donne si occupavano dei figli e della casa (oltre che del marito), delle responsabilità legate all’educazione della prole e del mantenimento della decenza famigliare. In ambito pubblico le donne non avevano alcun diritto: no al voto, no alle cariche politiche e, spesso, no anche all’istruzione superiore. Diciamo che se eri intraprendente, al massimo, potevi azzardarti a lavorare in fabbrica, sottopagata e in condizioni precarie, e sempre che tu non avessi un marito e i figli da seguire. Solo se eri la classica zitella o tuo marito si trovava al fronte ti potevi dar da fare senza troppo vociare su di te. La donna doveva essere responsabile, docile, accondiscendente. Non doveva mostrarsi più di quanto fosse strettamente necessario, la sua voce contava poco o nulla: l’uomo era al comando, la donna era solo una sua appendice. Una costola di Adamo.
Grazie Freud, ma quindi?
Ci sorprende quindi che le pazienti isteriche di Freud fossero solo donne? Beh, a me no. Erano persone silenziate, zittite, confinate. Erano persone la cui espressione era sempre limitata, la cui sessualità ed espressione di genere era rigida e imposta da altri. Erano persone che non sapevano cosa volesse dire parlare ed essere ascoltate. Fino a Freud che, astuto, ha deciso che il miglior modo per curare i loro sintomi, i segni di una salute mentale spezzata e di un animo in frantumi, fosse quello di lasciarle parlare, ascoltarle e raccogliere tutte le loro difficoltà su un taccuino. E loro sono state meglio, perché hanno parlato. Gli uomini già parlavano e venivano ascoltati, improbabile diventassero isterici.
Ora, per tornare alla domanda principale: la salute mentale segue dei ruoli di genere? No, o meglio, non proprio. Diciamo che i ruoli di genere sono strettamente correlati alla salute mentale delle persone, in quanto possono alimentare o soffocare la loro identità e le loro sicurezze, oltre a dettare le loro in-sicurezze. E questi ruoli di genere possono dare vita a varie forme di disagio psichico. Vediamo meglio come.
Un DCA per ogni genere: il femminile
Se il genere femminile è quello considerato più incline all’emotività e alla cura del prossimo, il suo DCA sarà necessariamente l’anoressia nervosa. Persone votate al sacrificio, alla privazione, all’attenzione verso ciò che è diverso da sé stesse sono coloro che si mostrano più inclini a comportamenti di stampo anoressico. La privazione del cibo (che nel ruolo della donna domestica assume poi innumerevoli significati, ma qui servirebbe un altro articolo) e le diete restrittive sono i primi sintomi di un DCA come l’anoressia nervosa. Inoltre, poi, la cultura della dieta propone modelli di femminilità che rispecchiano un certo standard: corpi magri, quasi invisibili, facilmente “controllabili”. Se ti allontani da questo schema, forse non sei femminile abbastanza. Non sorprendiamoci allora se i dati epidemiologici confermano che la maggioranza delle persone con anoressia nervosa siano donne. Proviamo a rifletterci, ricordandoci come stavano le donne quando Freud era all’opera e come stanno ora.
Se il genere maschile è quello che comanda, invece, la situazione cambia. Il ruolo del capitano presuppone forza, stabilità, sicurezza. Presuppone muscoli, allenamento, tempra. E quindi ci sorprendiamo se, ad oggi, il numero di soggetti di sesso maschile affetti da vigoressia è aumentato? La vigoressia è una forma di dismorfia corporea che si manifesta con l’ossessione per l’immagine fisica, in particolar modo per il tono muscolare e la massa magra. Si aggiunge a ciò, quasi come naturale conseguenza, un’ossessione anche per l’allenamento e le diete ipocaloriche e iperproteiche. Insomma, il maschio deve essere forte, nessuna scusa, e se non lo sei la tua mascolinità viene messa in dubbio.
Genere e DCA: non esiste una ricetta unica
Ora, spero sia stato chiaro il mio intento provocatorio e sarcastico in merito alla questione, ma mi sembra comunque necessario mettere qualche puntino sulle I. Quanto detto fino ad ora è una riflessione su quanto i ruoli di genere possano essere costrittivi e limitanti per moltissime persone, di entrambi i generi. Questi ruoli possono causare tanto dolore e sofferenza nel momento in cui non vengono rispettati e possono generare enormi ferite nella salute mentale delle persone.
Ovviamente, però, non esiste un solo modo di soffrire: non tutte le donne si ammalano di anoressia e non tutti gli uomini di vigoressia. Può accadere il contrario, così possono esserci infinite altre forme di espressione del disagio psichico, senza ricette.
Le mie estremizzazioni sono solamente un piccolo e disperato tentativo di stimolare una riflessione profonda sul mondo in cui viviamo e su quello in cui vorremmo vivere. Ogni dolore è valido in ogni sua forma, ma pensiamo a che bello sarebbe se certe cause di dolore non ci fossero più.
Fonti
S. Freud, Studi sull’isteria, 1895
V. Tuaillon, Fuori le palle. Privilegi e trappole della mascolinità, 2023