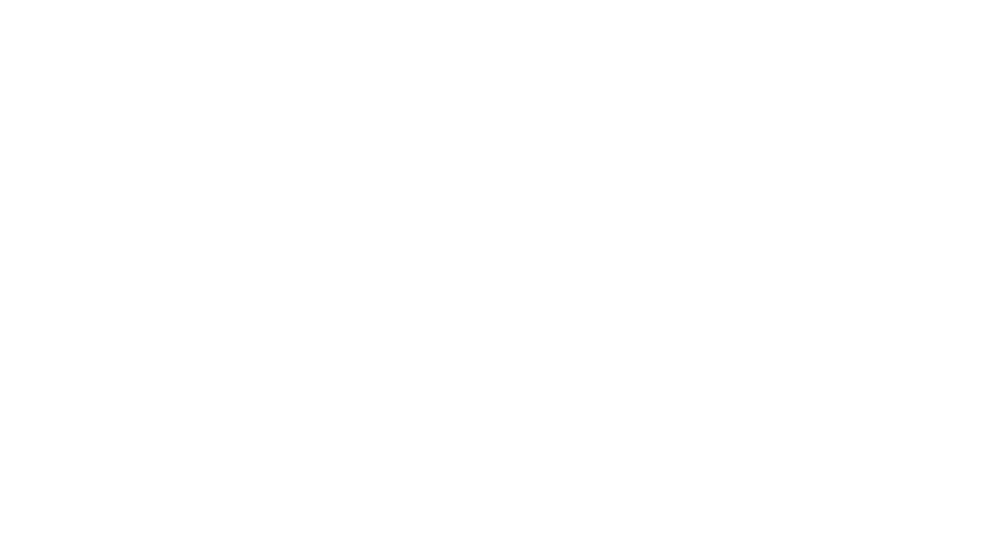Prendersi cura di una persona con disturbi del comportamento alimentare è molto spesso un lavoro a tempo pieno, ma raramente viene riconosciuto. Diversi studi dimostrano come lo stress che deriva dall’assistere un* car* con DCA può essere maggiore rispetto a quello causato dall’accudimento di una persona con depressione o schizofrenia. A ciò si accompagna un costante senso di preoccupazione che pervade la quotidianità rendendola sempre più soffocante.
La sfida dei disturbi alimentari per i genitori
Essere genitore di un* figli* con DCA è un’esperienza che mette a dura prova. Un DCA non influisce solo sulla persona che ne soffre, ma anche sull’intero sistema familiare. Si tratta di una continua sfida per chi accoglie, non per scelta, questo “ospite” che non ha chiesto il permesso di entrare nella propria vita. Questo disagio coinvolge tutte le persone vicine al paziente con DCA, le ingloba in una bolla che diventa sempre più angusta e soffocante. Ciò si ripercuote, con un effetto domino, su tutti i componenti della famiglia.
Di fronte a comportamenti che sembrano incomprensibili, è facile sentirsi impotenti, inutili o, addirittura, colpevoli. È fondamentale capire e accettare che i disturbi del comportamento alimentare presentano un’eziologia multifattoriale.
Per un caregiver è indispensabile trovare un equilibrio tra il desiderio di aiutare e il prendersi cura anche della propria salute mentale.
Il supporto da parte della famiglia
Un caregiver può rappresentare la chiave di volta nel percorso di guarigione e decretare quella curva verso la regressione o l’avanzamento del disturbo alimentare. Ascoltare e partecipare attivamente al trattamento non significa “invadere” il suo spazio, ma creare un clima di condivisione e uno spazio di comprensione.
È fondamentale stabilire un canale di comunicazione aperta, ponendo delle domande per capire come si sente la persona con DCA.
La costruzione di routine chiare e confini sani e stabili aiuta a stabilire piccole abitudini quotidiane e ottenere una relativa sicurezza.
Al caregiver viene spesso consigliato di informarsi e formarsi sui DCA, così da poterne riconoscere sin da subito di segnali ed evitare giudizi che possono ostacolare il recovery.
Cosa significa vivere accanto a una persona con DCA
I primi stati emotivi percepiti sono il disorientamento e la destabilizzazione. La quotidianità a cui si è sempre stati abituati viene totalmente stravolta. Ciò che prima era una certezza, adesso non lo è più.
Capita davvero di frequente che il senso di colpa e la rabbia incastrino i membri coinvolti in una spirale che contribuisc, non solo a mantenere, ma anche ad acuire il disagio. Focalizzarsi unicamente sulla ricerca “del colpevole”, sull’ipotetico errore compiuto, sull’evento scatenante, non fa altro che allontanare coloro che soffrono dalla possibilità di costruire un dialogo autentico. Il senso di colpa e la rabbia impediscono di vedere le possibili vie d’uscita, causano dissapori tra i familiari che spesso si incolpano a vicenda, alimentano e cronicizzano il DCA. Allo stesso modo, è importante non colpevolizzare chi è portatore della sofferenza sintomatologica.
La vergogna spesso provata sia da chi si trova in tale spirale che da chi ha vicino a sé contribuisce alla negazione del problema e all’isolamento. Sarebbe importante, invece, cercare un ambiente supportivo in cui confrontarsi.
Qual è il ruolo della famiglia?
La famiglia è molto importante per tutti gli individui, ma deve essere una vera risorsa e non diventare un ostacolo. Accade, a volte, che le famiglie delle persone con DCA, quando si rendono conto della malattia de* figl*, si “ammalino” di conseguenza. Rimanere incatenat* a questo tormento giornaliero non è d’aiuto né per sé stess* né per chi soffre di DCA, ma diventa inevitabile perché è un modo per contenere l’angoscia derivante dall’impotenza sperimentata.
Ciò che, invece, aiuta chi soffre di DCA è avere accanto dei familiari in grado di mettersi empaticamente nei loro panni, capire o intuire cosa possano sentire, imparare a vivere in quel periodo della loro vita e aiutarli ad affrontare le difficoltà.
Una delle prime domande che si pongono i genitori davanti alla diagnosi è “Di chi è la colpa?”. E la risposta che ne segue inevitabilmente sarà: “É colpa mia, perché in passato ho fatto, ho detto e, invece, avrei dovuto dire altro e/o fare diversamente”.
I genitori si interrogano su come hanno educato l* figl*, sugli eventi vissuti negli anni e sulle scelte operate ovviamente pensando al loro bene.
Generalmente, mettersi in discussione è un buon esercizio per verificare se si debbano attuare dei cambiamenti nei propri comportamenti o rimanere fermi sulle proprie convinzioni, ma non è detto che aiuti a capire ciò che sta accadendo realmente. Del resto, ricercare il “colpevole” può mettere la coscienza a posto e, quando si pensa di averlo trovato, si emette un giudizio, ma così facendo si chiude il pensiero e, di conseguenza, la comunicazione.
Pertanto, non è una buona cosa dare la colpa a noi o a chi soffre per la malattia o cercare il responsabile a tutti i costi, perché la soluzione non è così semplice e immediata. Il DCA cavalca e si nutre di dinamiche che, molto spesso, sfuggono alla logica. Si dice che questi disturbi, infatti, abbiano origini bio-psico-sociali, quindi è condizione necessaria che più variabili complesse si associno per dare il via a comportamenti patologici.
Il dialogo e il rapporto tra un paziente di DCA e la sua famiglia
Chi ha un DCA, in genere, da bambin* è l* figli* che molti genitori vorrebbero avere perché molto brav*, diligente, obbediente e adattabile.
A scuola generalmente sono bambin* o ragazz* studios*, che non danno problemi, salvo poi a diventare aggressiv*, scontros* e ribelli in fase preadolescenziale o adolescenziale. In questa fase, i genitori faticano a riconoscerl*e sono sorpresi della situazione conflittuale che si è venuta a creare, increduli che quella persona lì sia l* loro amat* figli*.
Se la comunicazione con i figli s’interrompe è difficile capire se si è visti come invasori o amorevoli sostenitori. Di norma, infatti, i genitori non pensano di essere vissuti dai figli e dalle figlie come invasori dello spazio psichico, ma pensano solo che stanno offrendo aiuto alla persona a loro più cara.
Il confine tra invadenza e guida/supporto è molto sottile. Dovrebbe essere fondamentale definire e concordare qual è il limite, come fare a rispettarlo da entrambi le parti e non darlo per scontato.
Quando nasce un bambin*, dovremmo ricordarci che nasce una persona diversa da noi e che non corrisponde mai ai nostri desideri o alle nostre aspettative. Sono altri individui da noi che possono arricchire la famiglia se riconosciuti nella loro unicità e se valorizzati.
È la scoperta dell’altro che ci deve guidare nel viaggio della nostra vita.
L’impatto del disturbo sui caregivers
I sintomi di un disturbo alimentare sono pervasivi e intrusivi all’interno della vita familiare e a questo si aggiungono le difficoltà relazionali che sono conseguenza del DCA.
Il burden
Oltre all’elevata emotività espressa, dagli studi condotti emerge come i caregivers risentano della situazione che vivono da avere una qualità di vita inferiore. Di conseguenza, di subire un impatto negativo sul proprio benessere individuale. È molto probabile, infatti, rilevare la presenza di un elevato livello di distress psicologico e di burden e, al contempo, livelli clinici di depressione e di ansia, soprattutto nelle madri.
Con il termine burden intendiamo “la misura in cui i caregiver percepiscono che il caregiving ha avuto un effetto negativo sul loro funzionamento emotivo, sociale, finanziario, fisico e spirituale”.
Inoltre, è possibile distinguere il burden oggettivo da quello soggettivo. Un burden oggettivo fa riferimento alle oggettive e concrete difficoltà di natura lavorativa, sociale, economica e di salute mentale che i caregivers si trovano a affrontare in seguito all’insorgenza del disturbo. Per burden soggettivo, invece, si considera la reazione soggettiva del singolo caregiver davanti alle suddette difficoltà.
L’esperienza dei caregivers secondo una ricerca
L’istituto di ricerca Equip ha condotto un sondaggio basato sulle esperienze di caregivers di persone con DCA. I principali obiettivi dell’indagine erano:
- Quantificare l’impatto dei disturbi alimentari sui caregivers
La ricerca mirava a valutare l’impatto emotivo, fisico e logistico del supporto a una persona cara durante il trattamento del disturbo alimentare. L’analisi ha esaminato anche come l’impatto possa variare a seconda del ruolo familiare del caregiver (per esempio: madre, padre, fratello, sorella, nonna, nonno, zio, zia, tutore etc.).
- Esplorare le lacune nel supporto
Fondamentale è informarsi di quali sono gli ambiti in cui i caregivers incontrano maggiori difficoltà, se ci sono settori in cui si sentono privi di supporto, esclusi o confusi. E, in più, i costi per l’accesso alle cure influenzano l’esperienza dei caregiver?
Dalle indagini condotte da Equip su oltre 1.000 persone, sono emersi i seguenti risultati:
- 1.075 persone a cui è stato somministra il sondaggio hanno dichiarato di essersi prese cura di qualcuno in fase di guarigione da un disturbo alimentare nei precedenti sette anni;
- Il genere dei caregivers era quasi equamente suddiviso con il 51% di donne e il 48% di uomini;
- Gli amici (27%) e i genitori (21%) rappresentavano la metà del campione dei caregivers intervistati;
- Le diagnosi più comuni che sono state registrate erano il disturbo da alimentazione incontrollata (BED) e l’anoressia.
Punti chiave dell’analisi dell’Equip
Sebbene fosse già noto che l’esperienza di assistenza è impegnativa, il sondaggio dell’Equip ha rivelato nuove prospettive. Tramite dati quantitativi e spunti illuminanti hanno illustrato meglio la realtà dell’assistere chi soffre di DCA durante il recovery.
- Mette alla prova chi sei
Oltre 7 caregiver su 10 (74%) affermano che il ruolo di caregiver della persona cara ha rimodellato la loro identità. Il 41% afferma che questo compito ha modificato la loro identità presente, modellandola e forgiando quella esistente, mentre il 33% afferma di aver sviluppato una propria identità di caregiver. Questa nuova identità comporta delle sfide. L’80% dei caregiver riferisce di sentirsi sopraffatto almeno una volta e oltre la metà (51%) afferma di lottare con stress e ansia.
- Sono soli
Quasi due terzi (65%) dei caregivers sono profondamente coinvolti nel trattamento. Il 94% ritiene che il loro supporto sia fondamentale per la guarigione. Spesso, però, sono lasciati da soli a gestire questa situazione particolarmente pesante e complessa. La maggior parte si affida ad amici e familiari (51%) per il supporto, ma circa 1 persona su 8 si sente completamente sola. Circa la metà degli intervistati ha cominciato un percorso terapeutico affiancati da clinici professionisti, molti altri, invece, denunciano una mancanza di supporto emotivo. Molti hanno sottolineato la necessità di prezzi accessibili alla cure psicologiche per far fronte alle esigenze dell’assistenza.
- Hanno bisogno di essere formati
Il 57% degli intervistati desidera una maggiore informazione sui disturbi alimentari e il 45% necessita di terapia o gruppi di supporto incentrati sulla pratica del caregiving. Quasi 1 su 5 ha dovuto affrontare il percorso di recupero senza una guida. Quasi la metà (48%) si sente impreparata a gestire le ricadute.
Le difficoltà economiche che ne conseguono sono un altro fattore da tenere in considerazione: il 44% afferma che i costi delle cure gravano sulle proprie finanze. Conciliare l’assistenza con il lavoro e la famiglia è una lotta quotidiana per il 50%. C’è un forte desiderio di risorse centralizzate e facili da reperire, tra cui supporto finanziario, programmi strutturati e guida passo passo, soprattutto all’inizio del percorso di assistenza.
- Vogliono essere considerati e valorizzati per il ruolo familiare e sociale che ricoprono
I caregivers sono fortemente coinvolti nel percorso di recovery. Il 71% riferisce di preparare i pasti, il 60% di controllare l* propri* car* durante e dopo i pasti e il 55% gli/le fornisce regolarmente supporto emotivo durante il giorno. Eppure, molti riferiscono di sentirsi esclusi dal processo di trattamento e desiderano essere inclusi come partner preziosi. Gli intervistati hanno chiesto aggiornamenti costanti, trasparenza e strumenti per costruire fiducia ed efficacia nel loro ruolo.
- La ricerca della cura di sé è ancora una priorità
Un tema significativo che è emerso da quest’indagine è la necessità per i caregivers di dare priorità al proprio benessere. Prendersi cura della propria salute per evitare il burnout è complesso, ma necessario.
Caro caregiver…
I caregivers non devono essere mai lasciati soli sia dalle istituzioni che dai familiari, parenti, amici. I caregivers non dovrebbero mai esitare a chiedere aiuto, non solo per la persona di cui si prendono cura, ma anche per loro stessi.
L’articolo è stato scritto da Natalia, volontaria dell’Associazione