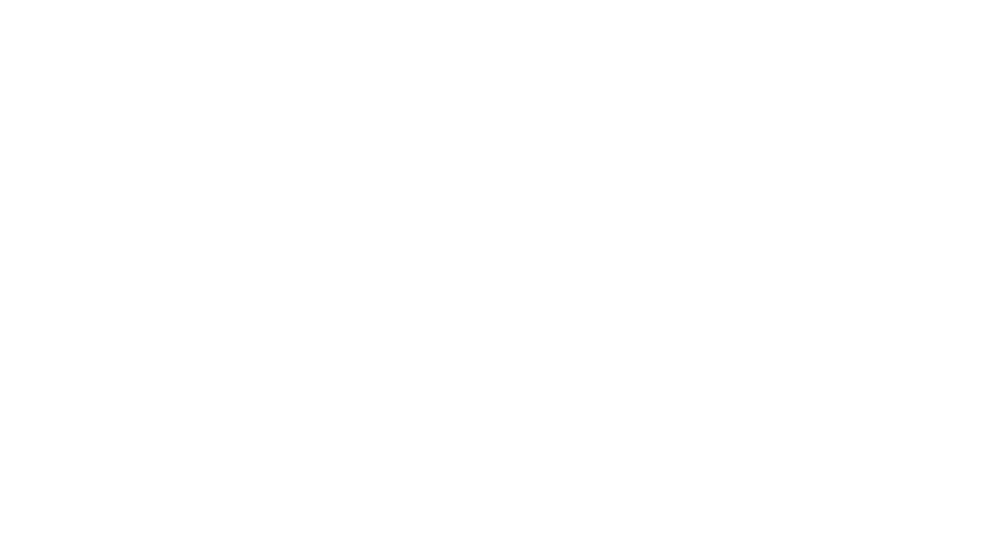L’esperienza catartica della terapia rappresenta un momento di “messa a nudo” di tutto ciò che, in quella fase della vita, ci angustia.
Capita di ripercorrere il proprio vissuto quotidiano e, all’interno di questo spazio intimo e personale, si ripropongono i medesimi schemi relazionali applicati fino a lì. E, proprio all’interno di questo angolo di riflessione, ci si trova a confrontarsi con un “altro”, diverso da noi: il/la terapeuta. Così, dall’esplorazione interiore di sé stessi si passa alla condivisione. Il/la terapeuta è, effettivamente, una figura verso la quale si può provare l’intera gamma delle emozioni umane, tra cui la vergogna e la paura del giudizio.
La vergogna di aprirsi al terapeuta
La psicoterapia è un percorso al quale il paziente si affaccia e che, con il trascorrere del tempo e l’aumentare delle sedute, può mostrare delle parti di sé e del proprio carattere che non gli piacciono. Si dialoga per riscoprire e approfondire delle sensazioni e ricordi legati a esperienze dolorose. Ciò può portare chi soffre di DCA a temere il giudizio del* terapeuta, a diffidare di poter essere realmente capito e accolto. Ed è proprio qua che la terapia psicologica rivela il suo potere trasformativo, e non per un merito speciale dello specialista ma per l’effetto provocato da un’esperienza emotiva diversa da quelle che hanno accompagnato fin lì il paziente.
Può capitare di percepirsi come inadeguati, sbagliati e colpevoli agli occhi del* terapeuta. Si può pensare di essere inopportun* o che le proprie reazioni siano esagerate. Alcuni pazienti arrivano a sospendere la psicoterapia perché si sentono troppo imbarazzati e non riescono a elaborare e gestire questa situazione che crea loro forte disagio. È fondamentale scrollarsi di dosso questo giudizio che nutriamo nei confronti di noi stess*.
Ma se il/la paziente riesce a tollerare e controllare questo suo pudore, potrà dare inizio a una nuova fase della terapia: un cambiamento di prospettiva e punto di vista che gli permette di vedere nell’altro una persona interessata a lui/lei, alle sue vicende ed empaticamente sintonizzato con i suoi vissuti.
Chi si sta aprendo alla psicoterapia si accorge che è possibile non vergognarsi. Si accorge che quelle parti di sé che si sono sempre considerate inaccettabili, in realtà, sono umanizzabili perchè sono il frutto della sofferenza di una persona che non ha alcuna colpa del suo dolore. Perché tra il/la terapeuta e il/la suo paziente non c’è nulla di indicibile.
La vergogna del* terapeuta
Dall’altro lato, però, esiste anche la vergogna provata dal* terapeuta. Dearing e Price-Tangney definiscono la vergogna del* terapeuta come “una reazione intensa e duratura a una minaccia al senso di identità del terapeuta che consiste nell’esposizione dei difetti fisici, emotivi o intellettuali del terapeuta che si verifica nel contesto della psicoterapia”. È “più intenso ed estremo dell’imbarazzo” perché riguarda il sé “in contrasto con l’attenzione sul comportamento“. Propongono un Modello di Supervisione degli Eventi Critici (CES) in cui “il supervisore aiuta il supervisionato a riconoscere il senso di vergogna” derivante da un’esperienza con un cliente e “facilita l’esplorazione dei sentimenti del supervisionato“.
DeYoung (2015) afferma: “i terapeuti devono fare il proprio lavoro“. In altre parole, l* terapeuti devono confrontarsi e affrontare i sentimenti di vergogna in modo che, quando vengono attivati dai/dalle pazienti, debbono essere in grado di sentirli, dargli un nome e scoprire dove vivono in loro stessi.
Il terapeuta “cura” e si prende cura
L’instaurarsi di un legame basato sulla fiducia, sull’empatia e sulla connessione emotiva tra l* terapeuta e l* pazienti è alla base della costruzione di quelli che saranno gli obiettivi della psicoterapia. Il supporto dell* specialista è, inoltre, fondamentale per riparare le cosiddette “rotture terapeutiche”. Queste sono le difficoltà intervenienti nella psicoterapia (cioè disaccordo sugli obiettivi, ritiro o allontanamento dalla terapia e sfiducia verso di essa).
Non bisogna temere il giudizio del* terapeuta
Non poche volte capita che le persone decidono di non affidarsi a un* psicolog* per paura che gli venga diagnosticato qualcosa che non va.
In realtà, l’aver subito un trauma, un abuso o una perdita ci collega alla nostra più ancestrale radice umana. Sono proprio le azioni che facciamo per risparmiarci una sofferenza emotiva, o il nostro modo di considerare le esperienze che viviamo che, spesso, provocano delle rotture in noi. Così nascono dei sintomi che danno voce il nostro malessere, manifestando l’insorgenza di problemi mentali.
Perché abbiamo paura di andare in psicoterapia?
Tra le tematiche da affrontare in una seduta dall* psicoterapeuta ce ne sono alcune che sono potenziale fonte di disagio per molt* che, spaventati, dall’idea di essere visti come dei “pazz*” preferiscono non avvicinarsi a questo tipo di esperienza. Tra queste, oltre ai DCA, le più frequenti sono soprattutto:
- La genitorialità (per esempio: non volere figli, aver dato in adozione un* figli*, pensare di non essere un bravo genitore etc.);
- L’essere sopravvissut* ad abusi fisici, psicologici o essere autore di abusi;
- La povertà;
- La disoccupazione;
- I precedenti penali;
- Le dipendenze da sostanze o dal gioco;
- L’orientamento sessuale;
- I pensieri suicidari e comportamenti autolesionistici;
- Le malattie fisiche o mentali;
La professionalità dell* psicoterapeuta risiede proprio nella capacità di creare un contesto sicuro e privo di pregiudizi, adattando il trattamento alle caratteristiche individuali dei pazienti. Tra queste, il background culturale, tratti di personalità, preferenze terapeutiche, convinzioni religiose o spirituali, identità di genere e orientamento sessuale.
Il rapporto tra terapeuta e persona continua tra una seduta e l’altra
Il tempo tra una seduta e l’altra è una vera e propria camera d’incubazione per l* specialista che, mettendo a punto le strategie terapeutiche più opportune e portando il lavoro fuori dallo studio, trasferisce queste riflessioni nel suo “mondo reale”. Potrebbe arrivare anche riconsiderare un’opinione espressa o un intervento fatto durante una seduta. Allo stesso modo, però, l* terapeuta, instillando dei dubbi nella mente del* su* paziente, mette in moto una macchina di pensieri che alimenteranno una consapevolezza di sé stess*, accompagnata a una rinnovata capacità di mettersi sempre e costantemente in discussione per evolversi giorno dopo giorno.
L’articolo è stato scritto da Natalia, volontaria dell’Associazione