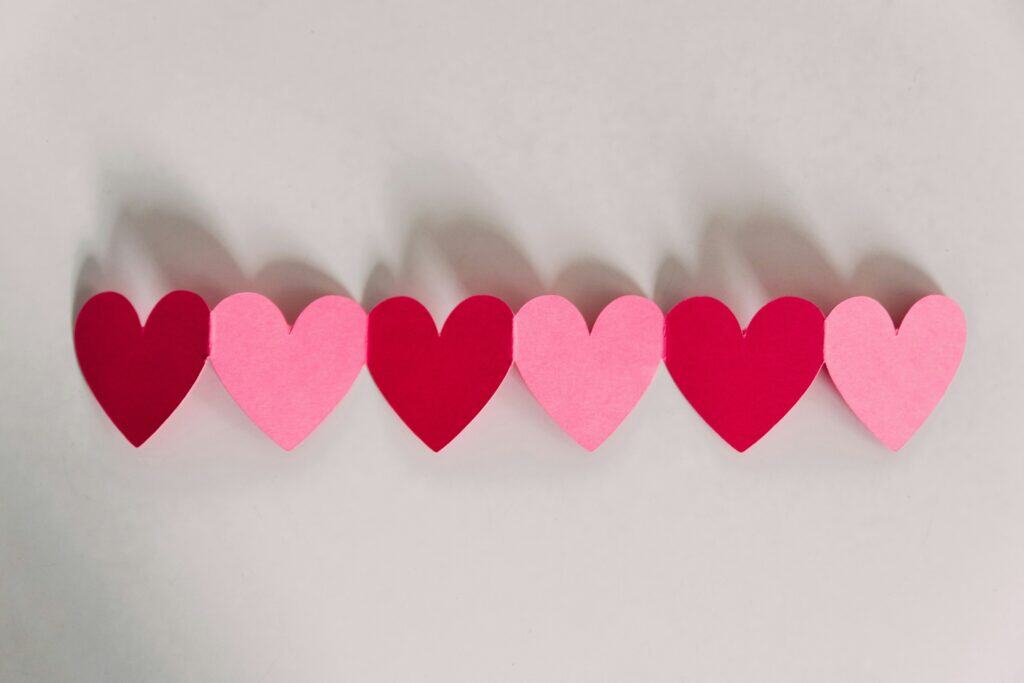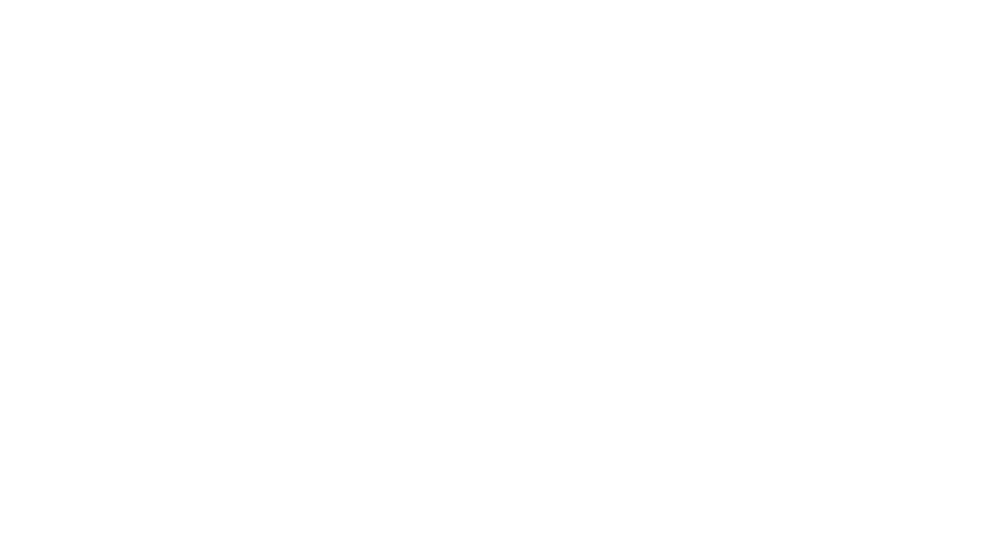Le relazioni amorose rappresentano uno degli aspetti più significativi della vita di molte persone, offrendo sostegno, intimità e crescita personale. Tuttavia, quando uno o entrambi i partner convivono con un Disturbo del Comportamento Alimentare (DCA), questa dinamica può diventare estremamente complessa, ricca di sfide emotive, comunicative e psicologiche. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche di tali relazioni, le difficoltà affrontate, e le strategie possibili per affrontarle, con un focus particolare sulle esperienze vissute dalle persone coinvolte.
Cos’è un DCA e il suo impatto sulla vita di coppia
I Disturbi del Comportamento Alimentare includono condizioni come l’anoressia nervosa, la bulimia nervosa, il disturbo da alimentazione incontrollata e altri pattern disfunzionali relativi all’alimentazione e all’immagine corporea (Fairburn & Harrison, 2003). Questi disturbi non coinvolgono semplicemente l’aspetto fisico, ma anche aspetti psicologici profondi quali bassa autostima, perfezionismo, ansia e difficoltà relazionali.
Nelle relazioni amorose, il DCA può influenzare vari aspetti:
– Comunicazione: le persone con DCA spesso manifestano segretezza, isolamento o difficoltà ad esprimere i propri bisogni emotivi.
– Intimità: il rapporto può essere caratterizzato da tensioni legate all’immagine corporea, alla sessualità e alla vulnerabilità.
– Ruoli di cura: il partner può assumere un ruolo di caregiver, talvolta in modo eccessivo, portando a squilibri di potere e a sentimenti di responsabilità eccessiva.
– Gestione dello stress: il DCA può essere un modo per affrontare ansia, insicurezze o traumi, complicando la gestione delle emozioni di coppia (Treasure et al., 2010).
Le sfide principali delle relazioni con un partner con DCA
Le relazioni con un partner che soffre di un DCA sono spesso caratterizzate da:
a) Comunicazione difficile: la paura di giudicare o di peggiorare il problema può portare la persona con DCA a evitare discussioni o a minimizzare i propri sentimenti, creando un muro di silenzio o incomprensione reciproca (Wonderlich et al., 2014).
b) Ruoli di cura e responsabilità: il partner può sentirsi responsabile del benessere dell’altro, assumendosi spesso il ruolo di “salvatore” o “protector”, che può portare a burnout emotivo.
c) Oscillazioni emotive: le persone con DCA possono manifestare cambiamenti repentini di umore, rabbia o tristezza, che rendono difficile mantenere una stabilità relazionale.
d) Impatto sulla vita sessuale: le preoccupazioni riguardanti l’immagine corporea, l’ansia o la perdita di desiderio possono compromettere l’intimità, creando distanza tra i partner.
e) Gestione delle crisi: episodi di crisi, come ricadute o comportamenti autolesivi, richiedono spesso interventi di emergenza e possono mettere a dura prova la stabilità della coppia (Pinheiro et al., 2018).
Le esperienze emotive e psicologiche dei partner
I partner di persone con DCA spesso vivono un mix di emozioni contrastanti: frustrazione, impotenza, senso di colpa, ansia e desiderio di aiutare. La mancanza di comprensione o di supporto professionale può portare a sentimenti di isolamento e di fallimento.
Uno studio di Pinheiro et al. (2018) evidenzia come i partner affrontino una “doppia sfida”: quella di sostenere il proprio partner mentre cercano di mantenere anche il proprio equilibrio emotivo. Spesso, il partner si sente diviso tra il desiderio di aiutare e la paura di peggiorare la situazione, alimentando sensi di colpa e insoddisfazione.
Inoltre, la paura di perdere l’altro, o di non essere sufficientemente efficaci nel supportarlo, può portare a una maggiore dipendenza emotiva o, al contrario, a un allontanamento per preservare il proprio benessere.
Strategie di gestione e supporto
Affrontare una relazione con un partner con DCA richiede spesso una combinazione di approcci terapeutici, comunicativi e di sostegno psicologico:
a) Educazione e consapevolezza: conoscere il disturbo, i suoi sintomi e le sue cause permette di sviluppare empatia e di ridurre giudizi e incomprensioni (Fairburn & Harrison, 2003).
b) Supporto professionale: terapia di coppia, individuale o familiare può aiutare a migliorare la comunicazione, a gestire le emozioni e a sviluppare strategie di coping efficaci (Treasure et al., 2010).
c) Stabilire limiti sani: il partner deve tutelare il proprio benessere, evitando di assumersi responsabilità eccessive o di sacrificare i propri bisogni.
d) Promuovere la collaborazione: lavorare insieme per sostenere il percorso di cura del partner con DCA, incoraggiando l’adesione alle terapie e alla nutrizione.
e) Autocura e rete di supporto: cercare il supporto di amici, gruppi di sostegno e professionisti per mantenere un equilibrio emotivo (NEDA, s.d.).
Bibliografia
– Fairburn, C. G., & Harrison, P. J. (2003). *Eating disorders.* The Lancet, 361(9355), 407-416.
– Pinheiro, L., et al. (2018). *The impact of partners’ support in the recovery of individuals with eating disorders.* Journal of Family Psychology, 32(4), 468-477.
– Treasure, J., Claudino, A. M., & Zucker, N. (2010). *Eating disorders.* The Lancet, 375(9714), 583-593.
– Wonderlich, S. A., et al. (2014). *The role of interpersonal factors in the development and maintenance of eating disorders.* Clinical Psychology Review, 34(4), 308-319.
Sitografia
– Istituto Superiore di Sanità (ISS) – Disturbi del comportamento alimentare: https://www.iss.it/
– National Eating Disorders Association (NEDA) – Support for loved ones: https://www.nationaleatingdisorders.org/
– Mental Health America – Eating Disorders: https://www.mhanational.org/
– European Eating Disorders Review – Research articles e approfondimenti: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10991611
L’articolo è stato scritto da Giovanna, volontaria dell’Associazione