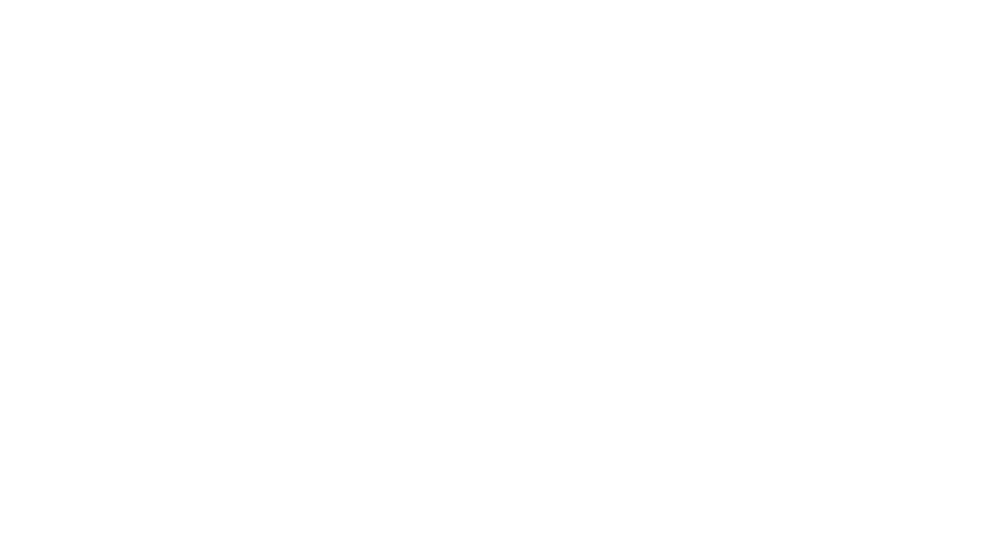Quando parliamo di stereotipo SWAG ci riferiamo all’idea scorretta che delinea il/la paziente “tipo” affetto/a da un disturbo del comportamento alimentare. Di fatto, il termine SWAG è l’acronimo di skinny, white, affluent girl (ragazza magra, bianca e benestante). Rappresenta un insieme di caratteristiche che, secondo lo stereotipo, sono tipiche di chi soffre di un disturbo del comportamento alimentare.
Il ruolo dei media nella creazione dello stereotipo SWAG
Negli anni, questa immagine è stata ampiamente diffusa dai media, contribuendo a radicare nella popolazione la credenza che i DCA siano malattie esclusive di un determinato gruppo demografico. Le vittime presentate dai telegiornali e le protagoniste dei film sul tema sono spesso rappresentate nel rispetto dello stereotipo in questione.
L’apprendimento e il consolidamento di stereotipi attraverso l’osservazione di ciò che viene proposto dai media è un fenomeno molto studiato in psicologia. Perché si formano? E perché vengono mantenuti?
L’esposizione ripetuta è una delle risposte. Se i film ci mostrano continuamente che gli ingegneri sono uomini, bianchi e di buona famiglia, tenderemo a credere che questa rappresentazione sia veritiera.
Questo accade anche quando parliamo di DCA: se i media ci espongono ripetutamente a immagini di pazienti con determinate caratteristiche, noi, senza esserne consapevoli, interiorizzeremo questa associazione e attribuiremo le caratteristiche alla categoria di riferimento.
La psicologia ci dice che l’esposizione frequente a un’affermazione o a un’immagine aumenta la probabilità che essa venga percepita come vera. Questo avviene indipendentemente dalla sua effettiva veridicità. Questo è noto come l’effetto di veridicità illusoria. I film, attraverso la ripetuta rappresentazione di stereotipi, possono far sembrare tali rappresentazioni più plausibili, accettabili e di conseguenza vere.
Inoltre l’essere umano per natura tende a cercare, favorire e ricordare meglio le informazioni che confermano le proprie credenze preesistenti. Questo fenomeno viene chiamato confirmation bias. Esso rappresenta un grande ostacolo per il cambiamento di credenze acquisite anche laddove esse si dimostrano false o non plausibili.
Queste sono alcune delle ragioni per cui è facile apprendere e mantenere stereotipi a partire dall’osservazione. Riconoscere che esistono questi fenomeni è un primo passo per sviluppare una visione critica dei contenuti a cui siamo esposti.
Perché lo stereotipo SWAG può essere dannoso
Questo tipo di stereotipo può risultare dannoso per le vittime in quanto, laddove queste ultime non si rivedono nelle caratteristiche che definiscono tale stereotipo, potrebbero avere maggiori difficoltà nel riconoscere di avere bisogno di aiuto. Questo può portare le persone a recarsi in visita da un professionista dopo molto tempo o, in casi estremi, anche mai.
Sembra banale ma non lo è.
Proviamo a vedere insieme un esempio. Se un paziente di sesso maschile ha interiorizzato la credenza che chi soffre di un DCA deve necessariamente essere donna, probabilmente faticherà ad accettare e riconoscere il proprio disturbo.
Se non possiedo le caratteristiche del paziente “tipo” e se si tratta di malattie esclusive del genere femminile, come posso io avere questa malattia?
Sarebbero domande e dubbi sensati se la credenza fosse vera. Ma non lo è. Probabilmente l’uomo portato ad accettare idee e credenze coerenti con lo stereotipo SWAG, riconoscerà molto più tardi di soffrire effettivamente di un DCA e, di conseguenza, si rivolgerà a professionisti con altrettanto ritardo.
Uno dei più importanti problemi quando si parla di disturbi del comportamento alimentare è proprio il ritardo con cui viene effettuata la diagnosi. È stato infatti dimostrato che più precocemente si inizia il trattamento, più alte sono le probabilità di successo.
Dunque appare evidente che per coloro che non possiedono le caratteristiche “tipiche” diffuse dallo stereotipo, la malattia possa essere ignorata e non trattata per diversi anni e come questo, possa risultare estremamente dannoso.
Età del paziente e status socio-economico
Lo stereotipo diffonde l’idea che i DCA colpiscono esclusivamente giovani adolescenti escludendo così una parte significativa della popolazione che non è immune a queste malattie. Adulti e anziani possono soffrire di DCA, tuttavia spesso le loro esperienze vengono ignorate o minimizzate perché non rientrano nell’immagine stereotipata. Anche la falsa credenza che i DCA siano malattie dei benestanti ha un ruolo non indifferente in questo processo. Questo preconcetto infatti, può far sì che individui provenienti da contesti socioeconomici meno privilegiati non riconoscano i sintomi di un DCA in se stessi o nei propri cari, perché credono erroneamente che tali disturbi non possano riguardarli.
I disturbi del comportamento alimentare nella popolazione maschile
In Italia, sono 3.600.000 le persone che soffrono di DCA e il 10% dei pazienti che hanno una diagnosi di anoressia nervosa sono maschi. Un dato che passa spesso erroneamente inosservato ma che è degno di attenzione, specialmente se consideriamo che gli uomini sono spesso più riluttanti delle donne a cercare aiuto. Di conseguenza, questi potrebbero essere malati pur non avendo mai ricevuto una diagnosi vera e propria.
Non è così sbagliato quindi ipotizzare che il dato sopra riportato (10%) possa essere sottovalutato.
L’anoressia nervosa non è l’unico DCA a interessare la popolazione maschile; anche la bulimia nervosa e il binge eating presentano dati significativi e, purtroppo, in aumento. Non sono poi da dimenticare i disturbi di recente introduzione all’interno del DSM-5 come la vigoressia e l’ortoressia che coinvolgono largamente questa fascia di popolazione.
Alla luce di questi dati, è ancora opportuno credere che si tratti di malattie esclusive della popolazione femminile?
L’appartenenza ad un gruppo etnico: quando può essere di ostacolo alla cura?
Come già detto nei paragrafi precedenti, lo stereotipo dipinge il disturbo alimentare come un problema principalmente di donne bianche, omettendo le esperienze di coloro che non rientrano in questa categoria demografica.
Le donne nere e gli uomini neri ad esempio sono spesso trascurati quando si parla di DCA a causa della percezione che non siano una popolazione “tipicamente” a rischio. Lo stigma associato ai DCA in questo gruppo etnico può rendere difficoltoso per le persone riconoscere di avere una malattia e cercare aiuto. Questa panoramica può essere ulteriormente aggravata dal mancato riconoscimento dei segnali di allarme da parte dei professionisti della salute qualora si attenessero allo stereotipo SWAG.
Il gap di riconoscimento e trattamento può avere conseguenze estremamente dannose sulla salute e il benessere degli individui non bianchi affetti da questi disturbi, evidenziando la necessità di un approccio più inclusivo e consapevole. Paula Edwards-Gayfield, consulente clinica della National Eating Disorders Association, si è espressa in merito all’argomento e ha affermato che “c’è ancora questo stigma su chi soffre di un disturbo alimentare e su come si presenta“. Ha inoltre aggiunto che lo stereotipo SWAG è talmente potente non solo da influenzare il pensiero del paziente, ma anche da contribuire alla diffusione di una definizione distorta dei DCA e dei pazienti affetti.
L’effetto dell’appartenenza a gruppi etnici sulla probabilità di ricevere una diagnosi è stato studiato da un gruppo di ricercatori. I risultati dello studio hanno messo in luce che anche di fronte a un quadro sintomatico identico, le probabilità di avere una diagnosi differivano a seconda della popolazione di appartenenza. Le donne bianche ricevevano una diagnosi nel 44% dei casi, le donne ispaniche nel 41% mentre per le donne nere la percentuale calava drasticamente raggiungendo solo l’11%.
Se pensi ad un paziente con DCA, qual è il primo aggettivo che ti viene in mente?
Le probabilità che tu abbia pensato al termine “magro/a” sono elevate.
L’errata associazione tra i disturbi dell’alimentazione e l’immagine di un corpo magro è radicata profondamente nella percezione pubblica.
Questa rappresentazione ha creato una narrativa limitata e fuorviante, che non solo esclude molte persone che non corrispondono a questo profilo fisico, ma limita anche la complessità e la diversità dei DCA a un solo sintomo visibile: la magrezza.
In realtà, i DCA comprendono una vasta gamma di sintomi e comportamenti che non sempre portano a una magrezza estrema e possono colpire individui di qualsiasi etnia, genere, età e classe sociale. Persistendo questa associazione errata, si rischia di trascurare o ritardare la diagnosi e il trattamento per quelle persone che non si adattano allo stereotipo del corpo magro, mettendo in pericolo la loro salute e il loro benessere psicologico.
I motivi psicologici per cui il termine “magro” viene facilmente associato ai disturbi dell’alimentazione sono diversi.
Questa tendenza può ad esempio derivare da un bisogno umano di semplificare la comprensione di problemi complessi. I DCA sono disturbi multifattoriali che coinvolgono aspetti biologici, psicologici, sociali e culturali. Ridurre tutto a un singolo sintomo visibile come la magrezza rende più facile per la mente categorizzare e riconoscere il problema, anche se questo porta a una comprensione distorta e estremamente limitata del fenomeno.
È fondamentale ricordare che queste malattie possono manifestarsi in molti modi diversi: persone con un DCA possono avere un peso corporeo normale o essere sovrappeso.
Oltre lo stereotipo SWAG e verso un approccio inclusivo
La complessità dei disturbi dell’alimentazione richiede una visione olistica che superi la semplice associazione alla magrezza. È importante continuare a sfidare gli stereotipi e promuovere una maggiore inclusione delle diverse forme che questi disturbi possono assumere, al fine di offrire supporto e cure appropriate per tutti coloro che ne sono affetti.
In conclusione, abbattere lo stereotipo SWAG significa dare voce e visibilità a tutte le persone che combattono con un DCA, promuovendo una cultura della comprensione e dell’inclusione.
Riflettiamo su come possiamo contribuire a cambiare questa narrativa, affinché nessuno debba più sentirsi sbagliato/a o non degno/a di aiuto a causa di una visione limitata e fuorviante.
Bibliografia
https://www.epicentro.iss.it/anoressia/epidemiologia
https://www.infodata.ilsole24ore.com/2023/04/04/in-tre-anni-i-disturbi-alimentari-sono -piu-che-raddoppiati-specie-fra-i-giovanissimi/
https://jeatdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40337-024-00983-4
L’articolo è stato scritto da Chiara, volontaria dell’Associazione